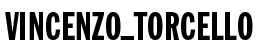Il volto, lo specchio e il ritratto o l’inferno della fobia
Scrivere in una nebbia di pensiero; ascoltare ciò che si vede; discernere rumori, destarsi alle immagini per trovar loro un senso preciso; sforzarsi di emergere per essere qualcosa o qualcuno; fornire ai propri occhi la prova della propria esistenza, questo è, riassumendo, un esercizio al quale ognuno di noi si dedica in permanenza senza averne coscienza e sovente senza riuscirci. L’arte e la scienza devono farne i conti. Partecipiamo ad una ricerca su noi stessi. Infermi, non dobbiamo dunque essere ciechi alle chiarezze.
Ogni mattina, ancora brumosi e non del tutto svegli procediamo alla nostra toilette. Enorme è il salto che ci fa passare dalla notte al giorno. L’indispensabile specchio della nostra stanza da bagno non è uno specchio magico. Al suo cospetto, cerchiamo di soddisfare agli imperativi dell’igiene. Per lo meno questo è il credo di noi civilizzati. Ma questo rituale mattinale è meno semplice di quanto non sembri. In realtà obbediamo a degli impulsi profondi. L’igiene è un alibi: un razionalismo a fior di pelle. Le cure che noi consacriamo alla nostra persona, e particolarmente al nostro viso, tradiscono intenzioni e ossessioni. Il corpo sarà vestito, ma il volto rimarrà a nudo. Che tallone d’Achille, se posso permettermi quest’immagine audace! Ed è allora che nello spolverarci ci sforziamo di comporre una maschera conforme all’ideale che abbiamo di noi. Questa maschera è destinata a soddisfare il nostro narcisismo e a dare agli altri un’immagine di marca seducente. Essere o non essere Dupont, Jean Raine o Torcello, questo è il problema.
Se ce ne sarà bisogno ci si rifarà, come si dice comunemente, una bellezza. Grottesco carnevale quello di Margherita nel Faust: “Ah rido di vedermi così bella in questo specchio… “. In effetti l’individuo rifiuta di riconoscersi nello specchio come nello sguardo altrui. Che affliggente miseria! Vogliamo comunque essere senza troppo apparire. Ecco il tessuto di contraddizioni nel quale ci imbattiamo come nella tela di un ragno.
Ma restiamo nella nostra stanza da bagno prima di varcare la soglia per affrontare il mondo esterno. Sono ben lontano dall’aver detto tutto sull’alchimia che ciascuno vi pratica. Sono certo che nessun pittore di ritratti o di nudi mi smentirà. Viso e organi sessuali sono due zone che, nello spirito e sulla tela, creano problemi. Eros! Quanto la bellezza può essere laida e la Venere anadiòmene! Baudelaire sapeva della possibilità di non imbruttirsi e che qualsiasi immagine è decomposizione. Ogni notte ci invecchia; il sogno non mente. Abbiamo un bel raderci i peli che adombrano il viso, passare al pettine la barba e i capelli ribelli per donare alla nostra fisionomia l’impressione di un giardino alla francese, un piccolo Trianon, ma tutto ciò è inutile, anche al prezzo delle cure più sofisticate. La vita sociale ne dà la prova. Le cortesie che ci scambiamo sono quelle di osservatori inattenti ma troppo astuti per smascherarsi l’un l’altro. È la regola del carnevale, tale è la commedia umana. Il tutto non è che miraggio e illusione ottica. Una emozione, qualche stanchezza, smorfie e tic, uno sguardo che la sa lunga ed ecco scompigliato questo bell’ordinamento. Non dimentichiamo che se ogni attitudine del nostro corpo è un linguaggio significativo, il viso è invece un luogo privilegiato ed è il più espressivo della nostra persona. La sua morfologia per mezzo della concentrazione degli organi sensoriali lo fa vibrare in una metamorfosi senza tregua, malgrado le precauzioni che prendiamo. Come si dice comunemente noi tentiamo di controllarci. Vana impresa. Il viso è arguto come quello di Scapin e ci tradisce. Basta osservare la differenza tra una fotografia per la quale noi posiamo ed una istantanea presa a nostra insaputa. Per un nulla in questo ultimo caso si farebbe causa al fotografo.
Innegabilmente vediamo che il problema della figurazione non è così semplice. Per il pittore diventa ancor più complesso. Se il ritrattista vuole sfuggire alla trappola tesa dal proprio modello, dovrà davanti al “vantaggio” e all’artificialità essere attento al momento in cui la posa si allenta. Coglierà gli istanti in cui le emozioni affiorano e dipingerà con un massimo di espressività, libero di oltraggiare la visione intravista. Un buon ritratto, per questo, dev’essere, per quanto sia poco espressionista, libero di scontentare il cliente. Rembrandt e altri hanno in altri tempi pagato caramente questa prassi che pareva singolare all’epoca. Fossero stati contemporanei di Kokoschka, la loro sorte sarebbe stata meno infelice. Questi pittori si sono preoccupati meno dell’involucro che dei sentimenti che li contiene. L’arte non è gioco ma materia da conoscere profondamente. È la ragione per la quale mi sento a mio agio parlando di Vincenzo Torcello e del rapporto privilegiato che intratteniamo.
Torcello non è ritrattista di mestiere, non più di quanto sia un pittore di marine, di tramonti e di qualche altro “genere”. È nel senso autentico del termine, un pittore della sua epoca. Parente, nello spirito e nell’amirazione che ha per loro, di Bruegel, Bosch, di Franz Hals, di Turner, è realista nel rifiutare come loro le allegorie superficiali. C’è in lui un Nord che lo affascina. C’è anche tutto un romanticismo che Novalis, Hoederlin, Nevral, Picard, Freud (ciò sorprende) hanno incarnato. Anche pittori contemporanei gli sono vicini; Bonnard, Giacometti, Beckmann, Soutine, Fautrier. Possiamo trovare in lui anche una certa affinità per Cobra. Si annuncia un grande temporale. Tutto è scuro in Torcello che si situa agli antipodi di un Fra Angelico o dell’arte astratta freddamente geometrica. Torcello è pertanto lontano dal credere che ciò che è fatto per piacere cada necessariamente nella fiacchezza. Constata semplicemente che l’uomo è un animale fondamentalmente tragico, una caricatura perpetua. La Morte scrive Ghelderode, è la compagna obbligata del poeta drammatico. Cocteau, ne “L’Aigle a Deux Têtes”, esclama da parte sua: “Quando la felicità si tinge di tristezza cosa c’è di più magnifico!”. Le citazioni si potrebbero moltiplicare.
La realtà del nostro dopoguerra nell’Europa occidentale, non è più quella conosciuta dai nostri nonni. La Germania dopo il 1918 aveva dispiegato nel cinema le ali della pittura espressionista. Gli Alleati dovevano invece cedere alla frenesia di gioie oziose. Triste risveglio nel 1940, quando ci si accorse che la vita non era una commedia dove bastasse per far ridere recitare Don Giovanni e i cornuti. NO! I mercanti di sogno avevano commercializzato riso e gioie a poco prezzo, mentre i surrealisti, gli esistenzialisti per non citare anche loro, avevano scommesso sul diavolo. Erano vilipesi o sconosciuti.
Ecco che oggi questi precursori trionfano al di là di tutte le loro speranze. Ci si trastulla con l’orrore si fa all’amore con Dracula, nessuna finzione sembra irreale. Lo spavento è messo alla portata di tutte le borse. Ma a che prezzo! Il gusto dell’orrore non è più convincente nel celebre emistichio di Corneille dove Camilla indirizzando le sue imprecazioni ad Orazio conclude. “E morir di piacere”.
Oggi ci vuol ben altro che questo grido pur tuttavia sublime per far fremere. la realtà minaccia di essere atroce e la finzione non farà che anticipare. Questa proiezione nell’avvenire si è spesso rivelata scienza ingenua ma approssimativamente esatta. Il bisogno di controllare lo straripamento di questa finzione conducono Torcello a non superare i limiti del credibile. Questo pittore non è tra quelli che speculano sul bisogno d’orrore caratteristico del nostro tempo. Non farne il gioco è il dovere di ogni spirito lucido. Ben lontano dall’essere ottimisti per principio, nella nostre opere come nei nostri ritratti, fino all’ultimo istante noi vedremo non una fine del mondo ma un processo metafisico. Come per i bambini sussiste una folle speranza: poter mutare per liberarsi di un’angoscia. La paura è spesso liberatrice. Non si può ragionevolmente accettare di essere, di un mondo in perdizione, gli ultimi superstiti, soprattutto al prezzo di non essere né un insetto, né un robot, né una statua.
È la ragione profonda per cui Torcello non è mai all’agguato del minimo soggetto, non più che di una teoria, di quelle teorie che forniscono delle ricette e che fanno scuola. Egli ha la saggezza di pensare più di quanto dipinga. È per questo che gli undici ritratti che ha fatto di me sono un’illustrazione esemplare della serietà e della profondità del suo procedere. La nostra amicizia è di lunga data. Lui, ancora giovane mi ha visto invecchiare. Ad ogni nostro incontro, mi ha radiografato; da parte mia ho fatto lo stesso con lui. Bisognerebbe parlare, non di cemento ma di cemento armato per quanto riguarda la nostra conoscenza reciproca. È verso il 1973 che Vincenzo ha progettato una serie di miei ritratti. Durante tre anni è maturato il progetto. Senza neppur prendersi cura di fare degli schizzi, mi scrutava e mi parlava di questa serie come già ultimata. Poi un giorno dell’ottobre del 1976, ebbi la sorpresa di vederlo sbarcare a Rochetaillée.
Il tempo di comporre una tavolozza e mi ha detto: posa con la più assoluta libertà. Sii commediante, esibizionista, stanco, mefistofelico, sbronzo, angelico…
Undici giorni, undici ritratti. A parer mio ciò ha del miracolo! Nei dipinti di Torcello mi sento nella mia pelle.
A ben riflettere, un vetro non è più fedele di uno specchio quando interviene l’altrui percezione. La percezione di Vincenzo convive con le profondità del mio essere.
Qui finisce e ricomincia una storia.
Jean Raine, 1976