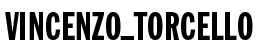Testo critico Stelio Rescio – 1978
L’opera di Vincenzo Torcello non è agevolmente inquadrabile nella pratica corrente nelle arti visive; la sua (e la contraddizione è solo apparente) è la “presenza” di un non allineato: “scomoda”, per chi si propone di darne conto criticamente, in quanto è negata ogni interpretazione per minimi scarti differenziali entro una “solidale” omogeneità del comunemente accettato (e codificato) quadro operativo.
Non fosse che per questo è un’esperienza salutare. Per ragioni che vanno al di là delle nostre inclinazioni “minoritaristiche”. In realtà la sua presa di distanza – netta anche se non dichiarata – rispetto agli abituali, tranquillizzanti schemi, ci consente di guardare ai modelli prevalenti nella ricerca attuale, da un punto di vista esterno; di sottrarci ad ogni sia pure involontario coinvolgimento nell’ “esistente” dato per meglio coglierne limiti e momenti involutivi. In primo luogo quel rarefarsi della consistenza oggettuale che si sfrangia e “assottiglia” fino a dissolvere lo stesso assunto della comunicazione visiva, stemperandone (e “inquinandone”) la specificità nell’esercitazione letteraria: davvero un bel risultato, in piena “civiltà delle immagini”. E che pensiamo sia almeno in parte da attribuire all’ormai acquisito dominio, da parte della struttura di gestione della società, sulla produzione iconografica e sulla sua circolazione di massa, espropriandone gli operatori estetici.
Oggetto dell’analisi (per restare al tema) è questa posizione defilata di Torcello. Come spiegarla? Non certo in termini di “ritardo”, visto che non gli sono ignote le esperienze che hanno segnato il nostro tempo, dall’arte concettuale alla sperimentazione metalinguistica; e dall’altra parte non ci si darebbe ragione del dato, inusuale, di una pratica operativa astratta che ha preceduto una fase espressionista, seguita a sua volta dal meditato ritorno ad una elaborazione liberata da ogni compromissione con gli oggetti (figura umana o cose), mai assunti, del resto, in funzione rappresentativa.
Torcello lavora ormai da un decennio: un’opera fervida e assidua, che ha proceduto traducendo in immagini dense di significato, istanze e motivazioni perseguite con indiscutibile tenacia. È abbastanza perché sia possibile fare un bilancio; tentare un esame inteso a cogliere nelle diverse e anche sensibilmente divaricate articolazioni del suo discorso, il filo di continuità che lo percorre. Soprattutto per prendere in mano il capo di questo filo. Individuabile, ci sembra, in una saldatura tra il “privato” e il “pubblico” che, pur proponendosi con un linguaggio atipico, è di una sorprendente attualità. E che è qualcosa di più di una mera connotazione soggettiva: rimanda alla matrice culturale da cui trae impulso e ragione l’opera di Torcello; “irregolare” anche in questo, appartiene – lui ligure – a quell’area culturale nord-europea alla quale è certo riconducibile la sua tensione ad una assunzione drammatica del mondo fortemente interiorizzata. Da qui – da questo suo con-fondersi con una realtà fisica che viene trascesa fino ad attingere una dimensione cosmica – la sua urgenza espressiva. (E si potrà anche dire che il ricorso è a categorie desuete ma non sappiamo, francamente, se questo ha il peso di un argomento. Ci sono esiti formali di tutto rispetto, una cultura, intenzionalità operative: sono da leggere).
C’è un momento iniziale (1969) in cui è la scomposizione della figura – mero schema astratto – a dirci la schizofrenia del mondo. È utilizzabile come chiave di lettura, osservando che nelle opere successive la spinta alla rottura libera una disinvolta immaginazione che stravolge i rapporti spaziali e tra le cose. Sono “paesaggi transitori” dove figura il più inverosimile inventario di oggetti: frammenti di realtà urbana, piante, autostrade, sole e luna posticci (da scenari di cartapesta), sequenze di lettere e di cifre, citazioni letterarie, elementi organici: “paysages cocktail” è il titolo di uno di questi lavori e vale per gli altri. Qui ad essere mimata, parodisticamente, è la dissennatezza dell’intero “ordine costituito” delle cose nessuna delle quali è al suo posto. Con una scelta, nell’uso discorsivo degli inserti di linguaggio, nel piglio irridente (sono ricorrenti “spazi a pois”), nell’ariosità che circola in alcune di queste tele che (a parte l’affinità con uno dei filoni della cultura figurativa francese) fa della trasgressione un gioco praticato con finta innocenza.
Torcello attraversa poi la sua “stagione all’inferno”. Risucchiato nella dimensione di una densa umoralità organica, e alla deformazione della figura che affida l’espressione dei suoi “stati dell’essere”. Riemerge, fino ad occupare l’intero campo, il dato biologico – esistenziale. Eppure in questo rapporto con la figura che egli evoca ossessivamente, devastandola, rimane altro da decifrare. Nei grumi di materia e nella violenza distruttiva con cui si accanisce contro l’oggetto – persona (si vedano gli “Undici ritratti per un’immagine”) il dato che interessa individuare – e che ci riconduce alla costante rinvenibile in tutta l’opera di Torcello – è il progressivo riassorbimento della figura da parte dello spazio, il suo esserne penetrata fino a disfarsi. È così riguadagnato il territorio dell’astrazione, che in lui acquista un significato preciso: la messa in crisi del reale, considerato, nella sua accezione codificata, mera apparenza, “effetto” degli investimenti allucinatori di cui carichiamo il mondo. Nei modi che gli sono propri, Torcello esprime quella critica della pseudo razionalità del nostro tempo alla quale, dopo il clamoroso fallimento dell’utopia illuminista, è pervenuta la stessa riflessione del pensiero materialistico. E per quanto ci riguarda è su questo punto che, pur da differenti opzioni culturali, registriamo un momento significativo di convergenza.
La messa in crisi dell’apparente naturalità dell’ “esistente” avviene qui come sgretolamento della consistenza fisica e destrutturazione della materia, fino ad annullare la separazione tra organico e inorganico, tra corpo e spazio. La esprime in immagini, segni, colore con un urgenza che stringe ad una sintesi dove materia ed energia si trasformano, convertendosi l’una nell’altra. È il processo di un continuo divenire i cui momenti Torcello registra, dandoci al tempo stesso la trascrizione di un “vissuto” segnato da una tensione totalizzante (non parlavamo di fusione, in lui, tra soggettività e concezione del mondo ?).
Lungo questo itinerario Torcello ha elaborato i suoi strumenti espressivi. E si comprende come a distinguere la sua esperienza – nella quale, per citare le sue parole, “l’oggetto è sempre visto come punto di riferimento delle nostre necessità dinamiche”- sia lo spessore e corposità della materia e l’incisività di un segno crudo, graffiante: connotati che sono evidenti soprattutto nella sua opera attuale. Ci interessa proporli, di contro ad un quadro nel quale a prevalere è l’esile vena di un asettico esercizio linguistico e formale che programmaticamente esclude la fisicità del nostro rapporto con le cose. A cui fa riscontro la insistita, compiaciuta esibizione, nella sua immediatezza irriflessa, del dato patologico e viscerale. E non a caso: un eccesso di rarefazione non reclama forse, nella meccanica degli equilibri, un eccesso di “corporeità?”.
In Torcello – lo abbiamo visto – il coinvolgimento nella “materia interiore” non manca. Ma ci viene restituito, anche laddove vi è più profondamente immerso, in modo sempre culturalmente mediato.
Stelio Rescio
Testo critico per la retrospettiva di Vincenzo Torcello presso la galleria il Brandale di Savona nel marzo del 1979